Mi piace pubblicare, seppur con
un ritardo di due anni, questa intervista a Stefano Massini, nata in occasione
del tour Premio Campiello 2017 per lo straordinario e geniale romanzo “Qualcosa
sui Lehman”. Una versione assai più ridotta di questa è uscita sul Giornale di
Vicenza. Molto era rimasto da sbobinare di una lunga intervista telefonica ad Asiago, fatta in auto con il sole cocente di luglio che arroventava sempre più l'abitacolo mentre un cane abbaiava senza sosta sovrapponendosi alla parole di Massini. Finalmente ho trovato il tempo.

Per Stefano Massini, autore del
sorprendente e corposo romanzo “Qualcosa sui Lehman” (Mondadori, pagg. 773), la
letteratura deve sempre avere anche un fine pratico, deve cioè aiutare a capire
la realtà che ci circonda. In tal senso la storia dei Lehman Brothers è in
grado di darci una nitida fotografia della nostra società nella quale la
ricchezza è divenuta il metro di valutazione di ogni cosa. In questo libro, che
trascende volutamente qualsiasi genere, lo scrittore e drammaturgo fiorentino
racconta, in modo avvincente e senza mai scadere nella retorica, l’epopea dei
Lehman dal 1844, quando il fondatore Henry parte dalla Germania e sbarca in
America, fino al rovinoso crollo del 2008. In mezzo tre generazioni di uomini
che via via si allontanano dalle loro radici, sostituendo i riti della cultura
e della religione ebraica, di cui Massini si rivela profondo conoscitore, con
quelli del capitalismo più cinico e sfrenato.
Come mai ha scelto di
affrontare un tema così ostico come quello della finanza attraverso la storia
dei Lehman?
La risposta è semplicissima: perché mi sono reso conto che,
da estraneo al mondo dell’economia, c’era soltanto una pagina, un fascicolo di
ogni quotidiano che saltavo a piè pari perché non lo capivo ed era l’insieme
delle pagine riguardanti l’economia. Questa parte del giornale la saltavo come
se proprio rinunciassi a capirla e credo che sia una cosa che fanno in molti.
Ad un certo punto mi sono però reso conto che era una cosa completamente senza
senso perché poche cose in realtà avevano una ricaduta su di me come
l’economia: io pagavo il mutuo, avevo delle ritenute sullo stipendio per cui in
qualche modo ero profondamente collegato al tema dell’economia, aveva delle
conseguenze profonde sulla mia vita quotidiana. È come se noi rinunciassimo a
capire il linguaggio dei medici perché è poco comprensibile ma in realtà ci
parlano di qualcosa che riguarda la nostra salute cioè una cosa alla quale
teniamo. Ecco è un po’ lo stesso. E allora ho deciso di scrivere qualcosa
sull’economia che servisse un po’ a spiegarla con parole semplici. Da qui è
nata la scelta di raccontare una storia di economia attraverso il filtro di una
grande storia familiare, di una grande storia di esseri umani che ce la mettono
tutta per affrontare i loro problemi e le sfide della società in cui vivono.
Lei all’inizio del
libro scrive, riferendosi ai Lehman, che non tutti potranno dire di essere
divenuti una metafora. Che metafora rappresentano a suo avviso?
Sono una metafora enorme di un fenomeno al quale tutti
abbiamo prestato pochissima attenzione ed è il fatto che nel corso del
Novecento siamo passati – e questo la storia dei Lehman lo racconta molto bene
– da una società bassata ancora sulla materia, sulla concretezza (nel caso dei
Lehman cominciano a lavorare il cotone, poi passano al caffè, al petrolio,
tutte cose concrete, che puoi toccare, sono insomma delle merci) al disprezzo
per tutto ciò che era materia, concreto, merce, e senza che ce ne rendessimo
conto il denaro ha iniziato ad essere usato non per finanziare delle merci ma
per comprare altro denaro, il denaro che
finanzia altro denaro e si è entrati in un mondo completamente scisso
dalla realtà in cui tutto è numerico, astratto, è un valzer di numeri. Questo è
evidente nella storia dei Lehman che sono passati da un negozio di stoffe ad
una grande holding internazionale.
Il libro racconta la
scalata economica dei Lehman Brothers attraverso tre generazioni. In che modo
si è documentato per questo libro? Quali sono le fonti storiche a cui ha
attinto? Dove finisce la realtà storica e comincia la finzione?
Mi sono documentato tantissimo, è stato un lavoro enorme. I
personaggi che io racconto sono tutti assolutamente veri, reali, non solo sono
assolutamente veri e reali ma anche i lineamenti del loro carattere, i modi di
essere, sono veri i matrimoni, è vero tutto quanto. Ci ho messo un anno a
informarmi prima di scrivere questo tomo così enorme. L’ho fatto perché
dobbiamo tener presente che negli Stati Uniti pronunciare il nome Lehman è un
po’ come se in Italia tu pronunciassi il nome Agnelli. Di queste famiglie si
conoscono le vicende, i figli, le dinamiche, i matrimoni. Negli Stati Uniti c’è
una ricca produzione riguardante la famiglia Lehman che qui da noi ovviamente è
meno famosa non essendo una famiglia italiana. È quindi tutto vero, chiaramente
quello che mi sono preso la libertà di inventare e di integrare è l’insieme
delle modalità che sono occorse per mostrare quelle personalità. Per cui i modi
in cui andarono gli incontri tra queste persone, le parole che questi si
dissero, quelle chiaramente sono invenzioni. È una forma di sceneggiatura,
ovviamente, però i personaggi sono reali, veri, anagraficamente inappuntabili.
Come dicevo prima ci ho messo molto tempo perché c’era una doppia
documentazione da fare: da una parte la storia vera della famiglia Lehman,
quindi chi erano, com’erano, dall’altra quella legata all’economia, c’era cioè
da fare un lavoro di apprendimento da parte mia su come funziona questo mondo
che non conoscevo.
In effetti è riuscito
nell’intento di rendere molto chiari concetti economici difficili e astrusi…
Questa è una delle cose che mi fanno più piacere. Quando
qualcuno viene da me e mi dice: guardi, grazie al suo libro ho capito qualcosa
che pensavo non avrei mai capito, per me è fantastico. Sono sempre stato
convinto che il teatro da un lato e ora che mi occupo di libri, i libri,
debbano sempre avere anche un obiettivo pratico, cioè devono essere utili,
devono darti delle forme per concepire e capire l’esistenza di tutto ciò che ti
sta ruotando intorno. Non deve necessariamente essere l’economia o una forma di
scienza, può anche essere un libro sui sentimenti umani, però deve esserci
qualcosa per cui un libro ti è utile. Per me questo è essenziale.
Questo libro mostra
anche come tutte le categorie novecentesche con cui noi interpretiamo tuttora
la realtà sono venute meno…
La sensazione che ho sempre avuto io è che con il cosiddetto
crollo delle ideologie si è in qualche modo imposto inevitabilmente un vuoto
che in qualche modo ancora non è stato superato, nel senso che noi tendiamo
ancora oggi, purtroppo, a leggere affannosamente la realtà con delle forme di
lettura non più adatte. Pensiamo alla politica che sta continuando, ancora oggi,
a cercare di risolvere i problemi con la dialettica tra destra e sinistra. Cioè
noi non abbiamo ancora superato uno schema interpretativo che evidentemente è
novecentesco. Secondo me la storia dei Lehman parla un po’ anche di questo
perché racconta che il mondo cambia inevitabilmente e vertiginosamente intorno
a chi lo popola, e chi lo abita dovrebbe cercare sempre – e questo, devo dire,
gran parte dei Lehman hanno cercato di farlo – di stare in ascolto di che cosa
l’umanità stava per chiedere. Questo ascolto si è rivelato poi fondamentale
perché hanno saputo prevenire alcune risposte dell’umanità come il computer o
quando si inventano quella che allora sembrava un’utopia cioè il fatto che ci
potesse essere una società interamente basata sul cinema. Chi potrebbe mai
pensare, compreso me, che una banca in realtà è artefice di capolavori del
cinema o di carriere di attori? Da un certo punto di vista, questa, questa è la
forza dell’economia.
Perché ha usato il
termine “qualcosa” nel titolo? In verità il libro racconta ampiamente e con
molti dettagli la scalata di questa famiglia…
È un titolo ironico infatti. C'è una cosa che a me preme
molto e a cui penso frequentemente in questo ultimo mese e mezzo di Campiello:
sono molto contento di essere arrivato finalista al Premio Campiello intanto
perché era la prima volta che scrivevo un libro e già essere arrivato nella
Cinquina dei finalisti è un successo; ma anche perché alla fine il Veneto così come
la Toscana dalla quale io vengo, sono terre che hanno saputo veramente
costruire un equilibrio economico incredibile sulla base dell’azienda a conduzione
familiare. Per cui trovo che la storia dei Lehman sia quanto mai al posto
giusto in questo premio perché è davvero la storia di una conduzione familiare
tanto che, quando muore Bobbie, l’ultimo dei Lehman, la mia storia va verso il
finale. Terminata la vita di colui che aveva dato per ultimo il cognome alla
banca senza avere eredi è chiaro che a questo punto la banca si perde. E questa
credo che sia una cosa tutto sommato bella perché è la dimostrazione, in
qualche modo, che le famiglie sono anche dei centri di produzione e questa
storia secondo me lo racconta anche nei suoi aspetti conflittuali attraverso le
liti fra i due fratelli, tra i padri e i figli. Le asperità ci sono, niente è
soltanto sorridente e bello. Io cerco di raccontare questa storia perché trovo
che non riguarda soltanto gli Stati Uniti, non riguarda soltanto la finanza
americana ma riguarda tutti noi.
Il punto di vista che
lei sceglie è quello un narratore onnisciente che però non giudica mai i suoi
personaggi. Sono i fatti, le azioni che compiono a porli davanti al tribunale
dei lettori. C’è una ragione per cui ha scelto questo punto di vista?
Provenire dal mondo del teatro mi ha molto aiutato perché in
teatro la retorica è pericolosissima e c’è una ragione fondamentale per cui
questo avviene secondo me: in teatro tu sei nel palcoscenico in carne ed ossa
quindi se dici qualcosa di retorico anche tu lo senti tornare addosso. A volte
invece nei libri è potenzialmente più facile essere retorici per il semplice
fatto che l’autore non c’è quando il lettore legge quindi è meno percepibile da
parte sua il luogo comune. Io ho cercato di stare attentissimo a questo
discorso ponendomi proprio in una condizione di non giudizio anche perché,
detto sinceramente, tutto voglio essere fuorché un difensore dell’alta finanza
che ha fatto gravi danni. Certo quando cominciai a scrivere i Lehman c’era
intorno a me, e c’è tuttora a distanza di anni, anzi forse è peggiorato, un
fortissimo sentimento antibancario e antieconomico. Oggi in questa Italia
reduce da enormi scandali come quello del Monte dei Paschi o delle banche del
Veneto c’è un forte sentimento antibancario per cui si dice che le banche sono
tutte ladre. In realtà il problema è molto più complesso perché fondamentalmente
stiamo parlando del cambiamento che ha avuto in questi ultimi anni il concetto
di ricchezza. Oggi la ricchezza è diventata tutto, lo spartiacque, il metro di
valutazione di tutto quanto, l’elemento determinante per tante cose. Pensiamo
nel mondo a quanti milionari sono stati eletti presidenti. Io però non devo far
percepire alcun giudizio, devo soltanto raccontare una storia. Tra l’altro alla
fine l’economia nel mio libro c’è, è un elemento potente, centrale, però è
anche secondaria perché questa è una storia di esseri umani, di famiglie, di
corteggiamenti, di liti, è una grande saga familiare. L’economia c’è ma è come
se andasse sullo sfondo, come se tu la vedessi in filigrana attraverso un
filtro che è quello della saga familiare.
In verità, accecati da
questo sentimento antibancario, spesso non teniamo conto che a muovere le
banche è il desiderio di arricchimento facile della gente. Nessuno in fondo è
innocente e questo nel libro appare chiaro…
Questa tra l’altro è una cosa che c’è anche nella nostra letteratura,
di tanto in tanto compare in modo molto chiaro ad esempio pensiamo a Pinocchio
quando mette da parte i soldi e li dà al Gatto e la Volpe perché gli dicono:
dammi i soldi, te li sotterriamo nel Campo dei miracoli e domani mattina
troverai il doppio senza sudare, senza faticare, senza lavorare. La voglia di
arricchirsi senza lavorare è uno dei grandi miti che ci portiamo dietro e che
nasconde anche delle grosse fregature. Evidentemente sotto questo punto di
vista dobbiamo essere onesti nel dirci che purtroppo siamo tutti noi che
vorremmo arricchirci senza faticare.
Il libro, nonostante
il tema, è ricco di momenti esilaranti e spassosissimi. L’’uso a piene mani che
lei fa dell’ironia e che è senz’altro la cifra dominate del romanzo sembra
quasi un modo per ridimensionare la religione dei soldi dei Lehman, per creare
una sorta di straniamento nel lettore rispetto alle vicende narrate… Era questo
il suo intento?
La risata è un elemento fondamentale per me ed è
fondamentale anche che venga scritto perché io a volte ho come la sensazione
che le persone vedendo il mio libro, vedendo la mole, sentendo che tratta di
economia è come se si impaurissero. Invece io credo che sia un libro che fa
anche ridere, poi c’è un elemento di ironia ebraica molto forte, molto dichiarato.
Questa è una storia che nasce ebraica, l’elemento yiddish è molto forte, non a
caso i Lehman sono ebrei che vengono dalla Germania. Quindi quando racconti una
storia che viene da quelle origini lì è inevitabile la forte presenza
dell’ironia yiddish e quindi la presa in giro di sé stessi e degli altri. Il
riso è determinante, imprescindibile nella cultura ebraica. Probabilmente
sentendo che questa era una vicenda per molti aspetti vissuta dalla società che
avrebbe accolto il mio libro come argomento ostico ho sentito più che mai il
bisogno di alleggerirlo e di dare al pubblico un premio. Per cui tu stai
leggendo una storia che sicuramente ti può impressionare perché è lunga e articolata,
ma io cerco di raccontarla in un modo che ti appassioni, infatti nel libro
succedono una miriade di fatti, il mio non è un libro teorico, non è un saggio,
è fatto di accadimenti, racconta un’avventura che poi è quella della
contemporaneità.
Può spiegarci meglio in
che modo è stato influenzato dall’ironia ebraica?
In tante altre culture, ad esempio in quella cattolica, ci
sono dei blocchi, delle cose delle quali non si può ridere. Anche nella nostra
cultura politica è così. Se tu vai a vedere i politici del dopoguerra
democristiani, comunisti e di destra, ti accorgi che il riso è completamente
bandito dal viso dei nostri politici perché nella tradizione anche di sinistra ridere
era considerato disdicevole. Per cui si devono aspettare decenni perché sul
viso dei nostri politici cominci a baluginare un sorriso. Ecco, nella cultura
ebraica, viceversa, tutto può essere oggetto di riso e di ironia e questo è un
elemento fortissimo e preponderante nella cultura ebraica e nella letteratura
ebraica come ad esempio in Kafka, un autore che ha avuto questa ironia anche tragica
per raccontare le cose. Tutto “La metamorfosi” di Kafka è basato su un assunto
profondamente ironico.
l libro è intriso di
cultura ebraica e Yiddish tanto che sembra scritto da un ebreo. Lei però non è
ebreo. Come ha fatto a raggiungere una conoscenza così approfondita e duttile
di questa cultura?
Questo nasce dalla mia biografia. Quando ero molto piccolo
mio padre strinse un’amicizia fortissima con uno degli anziani della comunità
ebraica di Firenze dove vivo. La moglie di quest’uomo era la maestra nella
scuola elementare ebraica di Firenze ed io quindi ho avuto la possibilità per
un po’ di tempo di avere un doppio insegnamento, cioè sia la scuola normale
italiana, sia la scuola ebraica. E questo per me è stato fondamentale perché mi
ha aperto gli occhi su una cultura completamente diversa rispetto alla mia e su
un mondo che altrimenti non avrei mai conosciuto. In qualche modo sono
cresciuto con un piede su due staffe, in quanto mi ritengo sia occidentale, sia
privo di origini, o perlomeno aperto al mondo, come tutto l’ebraismo che grazie
alla diaspora è aperto a tutte le grandi forme di contaminazione dei popoli con
cui il popolo ebraico è entrato in rapporto. Quindi è un mondo aperto alle più
disparate provenienze e per me questo è stato fondamentale per togliermi una
tendenza a parlare di cose solo italiane. Nei miei testi fino ad ora non ho mai
parlato di cose italiane. E ci sarà una ragione. In qualche modo credo che oggi
tutti, nell’era di internet, siamo cittadini del mondo, è cambiato profondamente
il mondo rispetto a quindici anni fa nel senso che oggi con un battito di
ciglia posso chattare con qualcuno che è in Australia. Questa facilità non è
priva di conseguenze nel nostro modo anche di raccontare le storie. Pensi che i
Lehman verrà messo in scena da uno dei più grandi registi di Hollywood che è
Sam Mendes. Questa è una cosa incredibilmente bella per chiunque oggi provi a
scrivere. Questa storia di un gruppo di ebrei tedeschi diventati americani viene
raccontata da un italiano e viene messa in scena da un inglese. È
la dimostrazione che di fatto oggi non esistono più patenti di pertinenza
geografica, tutti quanti possiamo raccontare delle storie che semplicemente ci
riguardano, perché riguardano il mondo intero.
Il protagonista principale
del libro è senz’altro il denaro. Tutto viene sacrificato in su nome. Eppure
nel passare da una generazione all’altra si nota una costante perdita di valori
morali e religiosi, uno scadimento umano sempre più evidente. Questo nel libro
vien ben messo in evidenza. Come mai ha voluto sottolineare questo fatto?
È assolutamente così per cui questa è anche la storia di un
progressivo allontanamento dalle proprie radici. Sia il papa Ratzinger sia papa
Bergoglio hanno parlato più di una volta dei rischi enormi del relativismo
oggi. Ecco questo libro parla anche del fatto che oggi tutto è relativizzato
rispetto al passato, e quindi i riti che i primi Lehman si portano dietro
dall’Europa vengono progressivamente considerati sempre meno importanti fino a
scadere in una dimenticanza generale. Rimangono soltanto come dei ricordi sullo
sfondo. In realtà però è complicato. Per esempio Bobbie, che è l’ultimo dei
nostri Lehamn, si allontana da questi riti perché ormai, quando qualcuno dei
Lehman muore, non è più vantaggioso sospendere tutta la produzione della banca per
un certo numero di giorni come in passato, per cui viene detto che si fa un
minuto di silenzio, che si mette la bandiera a mezz’asta. Però la memoria di
queste lontane origini rimane perché Bobbie alla fine è ossessionato durante la
notte da incubi e sogni, che sono un altro elemento portante di questo libro,
nei quali spesso sogna i profeti della tradizione ebraica che da piccolo
studiava, però li sogna in un modo deformato e narrativamente lontano dal
quella che è la Bibbia. Sicuramente il tema delle radici è molto presente.
Questo scadimento si
può legare ad una degenerazione della società nella quale vivono i Lehman?
Sì secondo me è legato all’aumento del senso denaro. Loro
finiscono per sostituire la religione delle origini con un’altra religione,
quella del capitalismo. Perdono i riti ebraici dell’inizio e li sostituiscono
con i riti del capitalismo più sfrenato e più micidiale.
Questo si vede bene
nel ruolo che assume il tempio: esso finisce per diventare non un luogo di
culto, ma un luogo di potere…
Esatto. Questa è la prova più inoppugnabile di quanto è
stato appena detto. Cioè il tempio viene vissuto come un luogo in cui la
posizione della famiglia all’interno dello schieramento dei membri del culto
viene vissuto come un simbolo di quanto la famiglia è potente.
Nonostante l’ironia
la visione che emerge nel libro dell’uomo e della società è cupissima. Sembra
che non vi sia alcuna via di salvezza e che tutti siano inchiodati al loro
destino. Nel romanzo alcuni Lehman, ad un certo punto, rinunciano a tutto e
scappano, ma non sembra esservi salvezza nella loro fuga.
Io non sono in grado di dire che cosa ci sarà dopo la pagina
che stiamo vivendo. Ricordiamoci che il fallimento dei Lehman è stato tra le
cause che hanno portato all’esplosione di quella grande crisi nella quale siamo
tuttora. Per cui noi viviamo ancora oggi le conseguenze di quello che è
raccontato nel libro. La smaterializzazione dell’economia di cui parlavo prima
poi ha avuto come conseguenza ciò in cui ci dibattiamo adesso. Che cosa ci sarà
dopo non lo so. Sono arrivato a raccontare in questo libro un passaggio
fondamentale che è la ragione per cui ad un certo punto un capitalismo troppo
basato sull’apoteosi del denaro, e parlo del denaro fine a sé stesso, ha
cominciato a mostrare il fianco ed è poi clamorosamente venuto giù. Io non so
dire dopo questa dimostrazione di plateale debolezza, se vogliamo di
insostenibilità di questo tipo di sistema, che cosa potrà esserci, perché io
faccio lo scrittore, non l’economista o il politico. Nel libro ho raccontato lo
scenario che stiamo vivendo adesso e cerco di andare alla ricerca delle cause
che hanno portato al fallimento di un colosso come i Lehman ma lo faccio da
narratore, non come un saggista, un economista o un politico. Io racconto una
storia. Come l’umanità potrà ad un certo punto risollevarsi da una pagina come
quella del crollo del capitalismo di cui Lehman sono stati il simbolo più
evidente non lo so dire e non ne ho idea. Probabilmente non ne hanno idea
neppure gli economisti perché stiamo un po’ procedendo lungo la costa, quando
si naviga con una nave lungo la costa è perché non si tende a prendere il largo
per paura che la barca non resista alla tempesta. Ecco, ancora stiamo
procedendo lungo costa e quindi tutto ciò che la letteratura può fare è
interrogarsi sulle cause di questo. Io l’ho fatto in modo radicale perché per
andare ad interrogarmi sulle cause sono andato a scomodare Adamo ed Eva, nel
senso che ho costruito una storia che parte prima della metà dell’Ottocento.
La crisi del 2008
però viene affrontata in poche pagine…
Questo l’ho fatto per una serie di ragioni. La più
importante è che i protagonisti del libro erano ormai usciti di scena perché
quando la banca va a morire non c’erano più i Lehman. Bobbie, l’ultimo Lehman,
muore nel 1969 senza eredi. Dal 1969 in poi non c’è stato più un Lehman
nell’amministrazione della banca, finiscono in mani ad altri e comincia il
definitivo crollo della banca. Però era già tutto scritto, nel senso che a quel
punto era chiaro che tutto ciò che si era manifestato prima esplode però non c’era
il bisogno di raccontarlo perché già era evidente il modo in cui era stato
costruito. Io racconto quella partita tremenda a squash, a ping pong, del greco
e dell’ungherese per il possesso della banca che non sono più evidentemente
Lehman e che rappresentano l’avvento di questa nuova generazione scriteriata di
persone che non avendo nel DNA la storia di quella banca non potevano portarla
avanti con la consapevolezza che i Lehman avevano dimostrato e che avevano
portato con sé.
I personaggi del
libro sognano molto e i sogni hanno spesso un valore rivelatorio. Come mai ha
dato questa importanza al mondo onirico?
Questo sarà molto più chiaro quando uscirà tra pochi mesi il
mio nuovo libro “L’interpretatore dei sogni” che mi ha occupato molti anni
parallelamente ai Lehman nel quale ho riscritto “L’interpretazione dei sogni”
di Sigmund Freud dal punto di vista romanzesco perché trovo che lì dentro ci
sia tutta la storia delle paure, delle fobie, degli incubi dell’uomo moderno.
Dovendo scrivere anche la storia dei Lehman non ho potuto non domandarmi che
cosa potessero sognare questi personaggi. Per me come autore è sempre
fondamentale farmi questa domanda: che cosa c’è di nascosto? In realtà i sogni
sono la nostra parte nascosta, tutto ciò che non osi dirti, sono le domande che
non osi porti, quindi per me è fondamentale chiedermi che cosa i personaggi non
vogliono dirsi e quindi di conseguenza che cosa sognano di notte. Ciò che non
vuoi dirti, inevitabilmente viene a visitarti quando chiudi gli occhi.
È vero che il libro
nasce prima oralmente dettandolo ad un registratore?
È verissimo ma non solo questo libro ma tutte le cose che ho
scritto. Il libro è scritto in movimento, è scritto per strada, andando in
bicicletta, registrato e poi sbobinato. Ciò rende la parola in movimento
anch’essa, essendo figlia di un movimento fisico. Questo per me è un elemento
imprescindibile ed è dimostrato anche da come il libro è scritto e impaginato:
io trovo sempre che il ritmo sia essenziale. Questo non è un libro scritto in
versi, infatti non c’è alcuno stralcio di metrica. È scritto in quel modo
soltanto perché io pongo un’attenzione micidiale alla parola come elemento di
ritmo e quindi ho scritto questo testo proprio come una specie di grande
ballata ritmica dove le parole sono ognuna degna di importanza e di interesse.
Il romanzo per molti
aspetti, dallo stile formulare alle ripetizioni all’uso dei versi, sembra un
poema epico aggiornato alla contemporaneità. Si ritrova in questa definizione?
In che modo è stato influenzato dall’epica classica?
Penso anch’io sia vicino all’epica. Molto spesso gioco in
modo ironico con l’epica. Gli eroi ci sono, anche se è antieroico il modo in
cui sono raccontati. C’è un modo di prendere in giro l’epica eroica.
Per quando riguarda il termine romanzo, dipende da che cosa
si intende: oggi le divisioni tra i generi sono sorpassate, sono saltate tutte.
Pensiamo al cinema. Nel cinema siamo addirittura arrivati al punto in cui un
documentario è entrato a pieno titolo tra il cinema non documentario tanto che
pochi anni fa, alla mostra del cinema di Venezia, il miglior film premiato è
stato un documentario, “Sacro Gra”.
Oppure quando uscì il libro “Gomorra”, ci fu un grande dibattito per
stabilire che cosa fosse. È un saggio o è un racconto? È un romanzo o un libro
di giornalismo? Io trovo che la forza straordinaria di quel libro e il
tentativo del mio sia proprio di non stare in nessun genere. Addirittura nel
mio libro è presente il fumetto. Ho ho voluto andare oltre ogni forma di genere,
perché i generi oggi sono completamente saltati. Basti pensare che le nuove
generazioni ascoltano la musica rap che in molti casi è scritta in metrica e in
rima. Che cosa vuol dire? Quella è poesia? No, non è poesia, è semplicemente
comunicazione. Oggi in una società in cui tutti scrivono, grazie anche ai
social, post, tweet è cambiato completamente e inevitabilmente il modo di
scrivere.
La storia dei Lehman
è nata inizialmente come testo teatrale (“La trilogia dei Lehman”) o è nato
prima il romanzo? Oltre alla struttura,
quali sono le principali differenze tra le due redazioni?
“Lehman trilogy”, il testo teatrale, è la versione tratta da
questo libro. Non è venuto prima il testo teatrale e poi il libro. Il libro è
quello che io scrissi, poi siccome uno spettacolo teatrale non poteva durare
dodici ore ho dovuto ridurlo in una dimensione più controllabile. Il libro
viene prima anche se è uscito dopo. Nella versione teatrale mancano molti
personaggi, perché chiaramente un’opera teatrale deve fare i conti con il
pubblico, non puoi tenerlo dodici ore in teatro. Nella parte teatrale, per
ovvie ragioni, ho dovuto rinunciare ad alcune cose. È solo questa la
differenza. Il testo teatrale è meno della metà del romanzo. Dal punto di vista
quantitativo è completamente un’altra cosa.
Stefano Massini scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, è
consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa. È volto noto
televisivo per i suoi racconti nella trasmissione Piazzapulita su La7.
Collabora con «la Repubblica». È lo scrittore italiano più rappresentato sui
palcoscenici internazionali; ha vinto sette premi della critica tra Francia,
Italia, Germania e Spagna; i suoi testi sono stati tradotti in 15 lingue. Il
suo “Lehman Trilogy”, ultima regia teatrale di Luca Ronconi, è stato messo in
scena da Sam Mendes per il National Theatre di Londra. Tra i suoi ultimi libri “Qualcosa
sui Lehman” (2016), “L’interpretatore dei sogni” (2017), “Dizionario
inesistente” (2018) pubblicati da Mondadori; per il Mulino «Lavoro» (2016) e “55
giorni. L'Italia senza Moro. Volti, immagini, storie da un paese in bilico”
(2018).

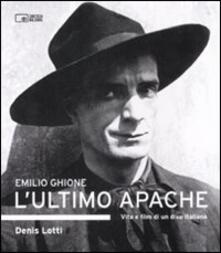


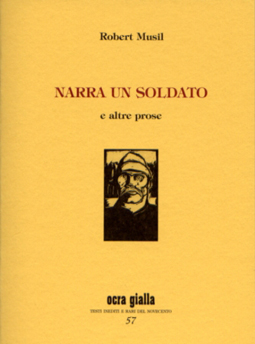
.jpg)
alta_def..jpg)

