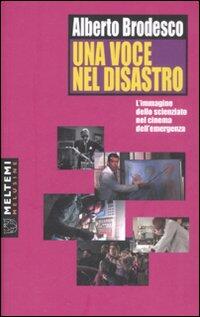(Articolo comparso, in forma più breve, sul
Giornale di Vicenza dell'11 agosto 2009)
di Fabio Giaretta
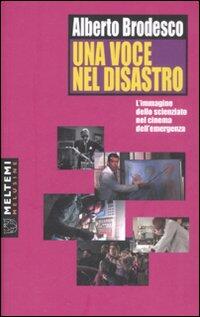
Fin dalle sue origini il cinema ha mostrato una forte attrazione per il disastro. Già in film come Collision et naufrage en mer (1898), Charmant voyages de noces (1899), Éruption volcanique à la Martinique (1902) di Georges Méliès, uno dei padri fondatori della settima arte, si può notare un precoce interesse per la rappresentazione della catastrofe. L’arte cinematografica, infatti, grazie all’uso delle immagini in movimento, ha la possibilità di far rivivere il disastro in diretta, rendendolo un’adrenalinica fonte di intrattenimento. Il cinema va quindi in cerca dell’evento catastrofico perché funziona dal punto di vista narrativo.
Da questo filone così longevo e popolare si possono ricavare anche interessanti considerazioni sociologiche. È quanto fa Alberto Brodesco nel suo appassionante saggio Una voce nel disastro. L’immagine dello scienziato nel cinema dell’emergenza (Meltemi editore, 190 pagine, 18 euro). Brodesco, nato a Malo nel 1975, dottorando in Studi Audiovisivi presso l'Università di Udine, parte dal presupposto che un’ondata di film sull’emergenza non è casuale, ma nasce da un humus sociale che va investigato. Il movimento non è però monodirezionale in quanto i film possono nello stesso tempo cambiare l’immaginario che li ha prodotti. Il libro si sofferma su quello che Brodesco definisce cinema dell’emergenza, categoria che comprende il cinema catastrofico (la minaccia riguarda una comunità circoscritta) e quello apocalittico (l’evento distruttivo mette a repentaglio le sorti di tutta l’umanità), soprattutto perché esso consente di studiare, nel modo più semplificato possibile, i rapporti tra società, politica e scienza, costrette dal pericolo ad una comunicazione immediata tra loro. L’intervento nella narrazione di una minaccia mortale per la collettività rende, infatti, maggiormente visibili le dinamiche sociali riducendole alle loro forme elementari.
Brodesco analizza con grande acutezza alcuni capitoli fondamentali della storia del cinema dell’emergenza, concentrandosi in particolare sulla figura dello scienziato. Questo viene rappresentato attraverso un campionario di stereotipi, non di rado contraddittori, che permettono tuttavia di capire come viene costruito e percepito socialmente il suo ruolo. Lo scienziato, al cinema, appare una figura ambigua, che oscilla tra due poli: può essere un distruttore oppure un salvatore dell’umanità.
Il cinema espressionista tedesco degli anni Venti e gli horror Universal degli anni Trenta, con film come Il gabinetto del dottor Caligari di R. Wiene, Il dottor Mabuse e Metropolis di F. Lang, Frankenstein di J. Whale offrono dei modelli decisivi nella rappresentazione dello scienziato. In questa fase prevale una sua funzione negativa. Vengono inoltre elaborati alcuni segni distintivi destinati a durare nel tempo: lo scienziato si muove nello spazio chiuso del suo laboratorio, indossa il camice, ha i capelli scompigliati (secondo il modello di Einstein, simbolo del cervello brillante ma ingovernabile che sta sotto), spesso ha un difetto fisico che ci mette in guardia su una possibile manchevolezza nella gestione della conoscenza.
Secondo le coordinate tracciate da Brodesco, il cinema dell’emergenza conosce la sua prima fioritura negli anni Cinquanta, nell’atmosfera della guerra fredda. In questo periodo la scienza sconta la scoperta della bomba atomica e quindi lo scienziato viene guardato con diffidenza, anche se può avere un ruolo sia positivo che negativo. È interessante notare come la paura del comunismo si materializzi sullo schermo attraverso l’inquietante figura del marziano.
Nel frattempo due film determinanti di S. Kubrick, Il dottor Stranamore (1964) e 2001 Odissea nello spazio (1968) fanno acquistare alla science-fiction una capacità di riflessione politico-filosofica che caratterizzerà il genere dagli anni Settanta in poi. Queste due opere mostrano quanto siano imperfetti i meccanismi di controllo elaborati dall’uomo e come la tecnologia contenga già in sé il germe del proprio fallimento.
Proprio negli anni Settanta, il cinema dell’emergenza torna ad un alto grado di popolarità, portando sullo schermo una visione più privata della catastrofe con i disaster-movie. Una delle pellicole simbolo di questo periodo è Lo squalo di S. Spielberg che favorisce la proliferazione di moltissimi film nei quali il pericolo proviene dal mondo animale. Lo scienziato continua ad essere una figura ambigua. Gli viene imputata una parte di colpa nella spiegazione della deriva del mondo ma nello stesso tempo, quando le cose vanno male, si ricorre sempre a lui.
Un nuovo evidente interesse per la tematica del disastro si ha negli anni che precedono il Duemila, con film come Independence day di R. Emmerich, Armageddon di M. Bay e molti altri, di pari passo con l’oscuro pericolo millenaristico collegato a questa data. Nei film dell’emergenza degli anni Duemila prevale il lato eroico dello scienziato, che tende ad assumere la parte del salvatore. In molte pellicole, il disastro si abbatte sulla città di New York, definita dall’architetto Le Corbusier “un cataclisma al rallentatore”. In alcuni film, fa notare Brodesco, è addirittura possibile scorgere una sconcertante anticipazione dell’11 settembre. In Armageddon, ad esempio, si vede una Twin Tower mozzata, con la cima fumante. Se isoliamo il fotogramma, esso appare indistinguibile da una ripresa dell’11 settembre.